
Javier Colomina (Madrid, 1974) è il rappresentante speciale del Segretario Generale della Nato per il vicinato meridionale. Colomina è entrato nell'Organizzazione nel 2017 come rappresentante permanente aggiunto della Spagna, è diventato vice segretario generale aggiunto per gli affari e la politica di sicurezza nel 2021.
Questa intervista è stata realizzata dal giornale online spagnolo El Confidencial nell'ambito del progetto collaborativo Pulse.
El Confidencial: cosa può dire di questo momento storico a nome dell'Alleanza atlantica?
Javier Colomina: Nei molti anni che ho dedicato alla diplomazia non ho mai visto un momento così instabile nelle relazioni internazionali. Ecco perché ora la Nato svolge un ruolo più che mai importante nel garantire stabilità e prosperità nella regione atlantica. Il numero di minacce e sfide è aumentato drammaticamente negli ultimi anni. Se la Nato non è rilevante in queste circostanze, non riesco a immaginare quando lo sarà.
Trump ha sollevato dubbi sull'impegno degli Stati Uniti nei confronti dell'Alleanza. Quanto è solido il legame transatlantico?
Capisco perfettamente che in Europa ci sia una reazione ansiosa e un po’ angosciata. Tutti abbiamo letto, ascoltato e visto cose che non ci piacciono. Ma la realtà è che in tutti gli incontri che abbiamo avuto a porte chiuse con i vari responsabili statunitensi, dal presidente Trump al suo consigliere nazionale per la sicurezza e ai vari segretari, abbiamo avuto conferma del loro impegno per una Nato solida e del rispetto dell’articolo 5 [che stabilisce che un attacco contro uno stato membro della Nato è un attacco contro l'intera alleanza e ne implica l'intervento].
Hanno però ribadito che i fattori dell'equazione transatlantica – gli Stati Uniti hanno dato molto a fronte di un impegno europeo piuttosto modesto – devono cambiare. La tendenza va invertita. Ma ciò che gli Stati Uniti mettono in campo rimane assolutamente essenziale. Tanto che oggi non ci sono alternative. E perché dovremmo cercare alternative a qualcosa che ha funzionato per 75 anni? Dobbiamo fare in modo che continui a funzionare nonostante le difficoltà.
Avrebbe senso una Nato senza gli Stati Uniti?
No. Perderebbe la sua ragion d'essere, la sua essenza. La Nato dipende dagli Stati Uniti per aspetti essenziali. Senza di loro, sarebbe un'altra cosa che, secondo me, non funzionerebbe. Quello che dobbiamo fare ora è lavorare per rafforzare il pilastro europeo dell'Alleanza. Gli Stati Uniti forniscono capacità militari che solo loro possiedono e la copertura nucleare, che è il cardine della nostra deterrenza. L'unico paese europeo ad avere una capacità nucleare autonoma è la Francia, ma il suo arsenale è limitato.
Il Regno Unito invece ha una capacità nucleare vincolata e dipendente da quella americana. Solo gli Stati Uniti sono in grado, per dimensioni e sofisticazione del loro arsenale, di usare il nucleare come strumento di deterrenza nei confronti di altre potenze nucleari con capacità comparabili, come la Russia e, tra qualche anno, sicuramente la Cina. Saremmo in grado noi europei di dotarci di una nostra capacità di dissuasione nucleare? Sarebbe complicato e aprirebbe molti dibattiti a livello nazionale.
Come sta attualmente il pilastro europeo della NATO? Potrebbe assumersi la responsabilità della sicurezza continentale in caso di un eventuale ritiro delle forze statunitensi?
La partenza delle truppe americane è stata una cosa che il presidente Trump ha ripetuto spesso in campagna elettorale. A oggi, tuttavia, non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione, né abbiamo elementi per pensare che ciò accadrà. E lo spostamento di truppe nelle proporzioni di cui si è parlato durante la campagna elettorale statunitense richiederebbe molti mesi di preparazione. È vero che c’è una forte presenza americana in Europa. In alcuni luoghi svolge una funzione assolutamente strategica di proiezione del potere statunitense, come in Spagna, in Italia o nel Nord Europa. Ma in altre zone, per mantenere le promesse elettorali, potrebbe forse essere richiamato solo un piccolo contingente. Di nuovo, però, non c'è alcun indizio, alcun messaggio in tal senso.
L'Europa potrebbe farsi carico di mantenere un cessate il fuoco in Ucraina?
Gli europei stanno lavorando molto seriamente per fornire garanzie di protezione all'Ucraina, che potrebbero assumere la forma di una forza di sicurezza. Alcuni paesi calcolano che sarebbero necessari tra i 20mila e i 30mila soldati; altri stimano che siano piuttosto 50mila o 100mila, a seconda delle funzioni e degli obiettivi di tale forza. In ogni caso riteniamo che gli Stati Uniti dovranno contribuire in qualche modo. Insisto, ci sono degli elementi insostituibili. La capacità di deterrenza di cui abbiamo già parlato, ma anche aspetti che sarebbero essenziali per una missione sul campo, come l'intelligence, il comando e il controllo, la logistica e i facilitatori.
L'Europa avrebbe sicuramente difficoltà a schierare, per esempio, 100mila soldati in Ucraina senza che ciò influisca sulla sua capacità di dispiegamento su altri fronti. È quindi necessario che la Nato continui a partecipare ai colloqui in corso. Gli europei stanno facendo ciò che devono fare, guidati da Francia e Regno Unito. Ma è importante avere una visione d'insieme di tutte le minacce attualmente presenti nel mondo in modo che la nostra difesa collettiva non ne risenta.
Tra il 24 e il 26 giugno si terrà l'annuale vertice della Nato a L’Aia. Quali sono i punti chiave in agenda?
È ancora presto e gli alleati dovranno sedersi a discutere l'agenda per il prossimo vertice. Inoltre, la nuova amministrazione americana non è ancora completamente formata. Ma sarà difficile che i temi principali non siano l'Ucraina, l'industria e gli investimenti nella difesa. Soprattutto quest'ultimo aspetto. Al vertice di Washington, a cui ha partecipato il presidente Biden, è stato detto chiaramente che il 2 per cento (del pil destinato alla difesa) era una quota minima e non un tetto massimo. L'analisi delle nostre esigenze militari ci portava già allora a parlare chiaramente di un superamento di questa soglia.
Quanto di più, ci chiediamo tutti?
Sarà più vicino al 3 che al 2 per cento. E, forse, anche di più. Ma ci sarà una negoziazione, che non sarà facile, sulla cifra in sé, e su come calcolarla, e quali componenti, contributi e attrezzature prevederà.
Paesi come la Spagna criticano da molto tempo la formula adottata finora per misurare lo sforzo per la difesa. Sarà possibile cambiarla?
È impossibile sapere cosa conterrà la nuova equazione, ma probabilmente avrà nuovi elementi. Gli obiettivi fissati dall’accordo raggiunto nel vertice Nato in Galles del 2014 saranno mantenuti e credo che il calcolo sarà un po' più complesso, così da soddisfare tutti. La cifra del 3 per cento è problematica non solo per la Spagna, ma anche per molti altri paesi come l'Italia o il Canada. La Francia è al 2 per cento e salire al 3 per cento significherebbe passare da 50 miliardi a circa 75. Lo stesso Regno Unito, uno dei grandi paesi che più investe in difesa, ha annunciato un impegno del 2,5 per cento, da portare al 3 per cento solo tra qualche anno, e forse non sarà nemmeno sufficiente. Vedremo come andranno i colloqui. Quello che dobbiamo fare è raggiungere il 2 per cento prima del vertice ed è un messaggio che il Segretario Generale ha trasmesso con chiarezza a tutti i suoi omologhi.
Prima?
Prima del vertice o almeno nel 2025. È ciò che chiede la stessa Unione europea. Il piano sembra chiaro. Ci sono 150 miliardi che verrebbero – i dettagli non sono ancora noti – dalle istituzioni europee. Ma i restanti 650 miliardi sono soldi che devono uscire dalle casse dei singoli stati. Bruxelles sta dicendo: dovete spendere più del 2 per cento. Già solo con questa misura arriverebbero decine di miliardi di euro dai paesi che non hanno ancora raggiunto quella soglia. Questo sarebbe già un progresso molto significativo. E poi dobbiamo continuare a pianificare gli investimenti nella difesa per raggiungere gli obiettivi di capacità che noi stessi abbiamo concordato nel quadro della Nato.
L'Unione europea è impegnata nel proprio piano di riarmo. Sono strategie parallele? Possono esserci sinergie?
Devono esserci sinergie. Abbiamo un ottimo rapporto con l'Unione europea. Il segretario generale Rutte è stato per 14 anni primo ministro di un paese che sedeva nel Consiglio europeo. Conosce molto bene i suoi colleghi e le strutture dell'Unione. Il programma lanciato dalla Commissione europea deve far parte della strategia transatlantica. Più che un'alternativa, deve essere complementare alle capacità transatlantiche, e in particolare a quelle nordamericane.
Lo scorso anno è stato nominato inviato speciale del Segretario generale per il vicinato meridionale, quello che chiamiamo il fianco sud, una delle maggiori sfide per la sicurezza della Spagna. Qual è la situazione e che evoluzione vede?
Sono convinto che nel prossimo decennio dovremo convivere con questa instabilità nel Sahel e che queste minacce spingeranno a loro volta il Maghreb verso una maggiore fragilità. Questa situazione sta già raggiungendo il Mediterraneo e continuerà a influenzarci direttamente in termini di terrorismo, migrazione irregolare e traffici illeciti. Molte delle cose brutte che accadono nel mondo nel Sahel assumono dimensioni terribili. In molti paesi del Sahel non c'è quasi nessun controllo territoriale da parte dello stato.
Per questo motivo sarà importante che i paesi che hanno spinto maggiormente per riconoscere la priorità del fianco sud, in particolare Spagna, Italia e Portogallo insieme al resto degli alleati che sono già di questo avviso, continuino a insistere in modo coerente su questo aspetto. È vero che le minacce a est, e in particolare quella russa, sono le più imminenti dal punto di vista convenzionale. Ma è anche vero che i paesi di quella regione continuano a ribadirlo in modo più coerente rispetto a quelli del sud, che forse sono meno strategici e hanno una minor cultura della difesa.
Il ritiro strategico degli Stati Uniti potrebbe anche riaccendere vecchi rancori e vendette, incoraggiare i capi militari o favorire l’ingresso di altri rivali strategici, come la Russia o la Cina. Siamo pronti?
Ci sono infiniti elementi da prendere in considerazione in una crisi come quella del Sahel. Ma un dato importante è il passo indietro che ha deciso di fare l'Occidente. E quando ciò accade, di solito la Russia è lì pronta in attesa. E, sempre più spesso, anche la Cina o l'Iran. E questi paesi non fanno passi indietro. Al contrario, quando vedono che lo facciamo noi, restano alla porta decisi a entrare costi quel che costi.
Non illudiamoci, gli Stati Uniti sono il paese con la maggiore capacità di presenza geostrategica nel mondo. E se gli Usa hanno molta più capacità militare e hard power di noi, in soft power la distanza raddoppia. È evidente che decisioni come il ritiro dell'USAID avranno un impatto significativo sulla presenza dell'Occidente nel Sud globale. È importante che gli Stati Uniti mantengano il loro impegno, e bisognerà lavorare su aspetti e prospettive di politica estera e di difesa che siano sufficientemente rilevanti e che si adattino alle priorità nazionali nordamericane, come la lotta contro il terrorismo, l'Iran o la Cina. Probabilmente l’approccio americano diventerà più transazionale, meno altruista, per così dire; ma il loro impegno è essenziale per il lavoro che possiamo fare nella Nato nel vicinato meridionale.
Corriamo il rischio di reagire in modo eccessivo?
Il rumore in questi giorni è enorme e, naturalmente, rende molto difficile prendere decisioni e vedere la situazione con chiarezza, soprattutto quando sentiamo cose che ci sembrano inaccettabili o difficili da digerire. Ma dobbiamo continuare a concentrarci su ciò che è essenziale, cioè, per noi, il legame transatlantico. È comprensibile, poiché la cittadinanza e la vita politica vivono nell'immediato, nei cicli elettorali, e quindi rispondono a impulsi molto più rapidi di quanto richieda una strategia di sicurezza e difesa. Nel campo della geostrategia e della difesa si guarda più a lungo termine. I cicli dell'industria della difesa, per esempio, sono molto lunghi. Dal punto di vista militare e della sicurezza, ha poco senso fare quindi piani a tre o quattro anni. Dobbiamo cercare di essere realistici.
Si parla molto del fatto che le industrie, le forze armate e i paesi devono adattarsi ai tempi ed essere più flessibili. La Nato potrebbe cambiare su questioni cruciali come l'unanimità?
Non è necessario e non è all'ordine del giorno. La Nato è un'alleanza che si basa sulla condivisione di una serie di valori superiori, come la difesa e la sicurezza collettiva. Pertanto, la forza dell'Alleanza sta nella capacità dei 32 alleati di decidere insieme. Ho partecipato e presieduto molti negoziati complessi in cui a volte sembrava impossibile raggiungere un accordo. Ma alla fine si cede sempre mettendo gli interessi della Nato al di sopra di quelli nazionali.
Potremmo mai vedere un europeo come capo militare della Nato?
A oggi mi sembra molto improbabile, quasi impossibile, percorrere questa strada. Un comando non statunitense non avrebbe l'influenza e il potere sulle capacità militari che forniscono gli Stati Uniti. E senza la forza militare degli Stati Uniti, l’essenza stessa della Nato sarebbe messa in discussione.
👉 L'articolo originale su El Confidencial
🤝 Questo articolo fa parte del progetto collaborativo PULSE
Ti piace quello che facciamo?
Contribuisci a far vivere un giornalismo europeo e multilingue, in accesso libero e senza pubblicità. Il tuo dono, puntuale o regolare, garantisce l’indipendenza della nostra redazione. Grazie!









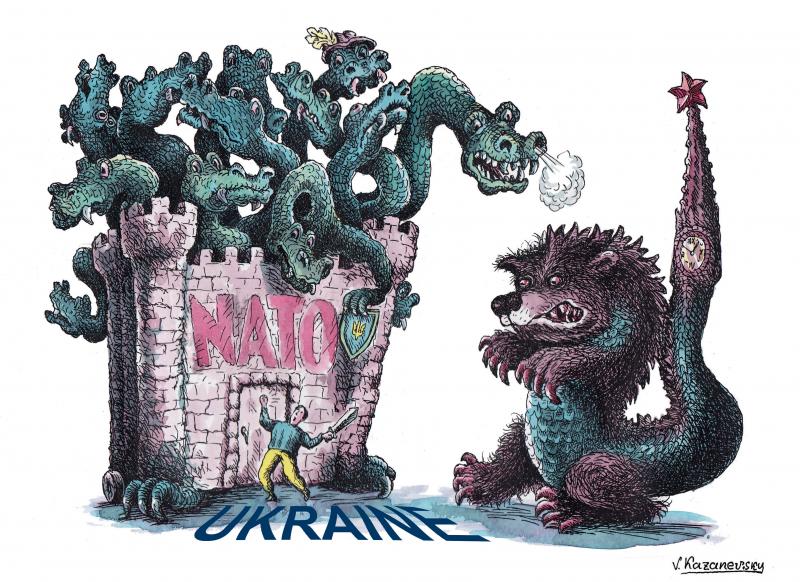



Partecipa alla discussione
Divento membro per tradurre i commenti e partecipare