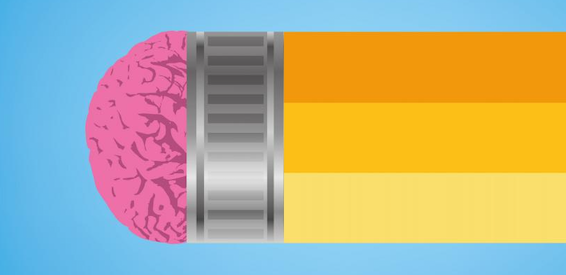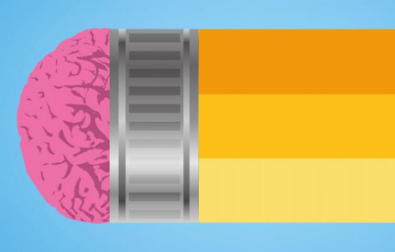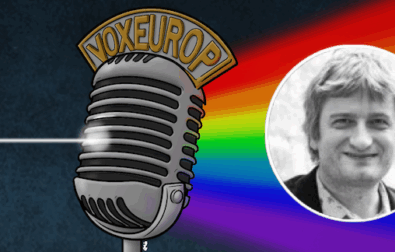C’erano pochi dubbi sul fatto che il 2025 sarebbe stato un pessimo anno per la democrazia. Alla fine si è rivelato molto peggio di quanto molti di noi si aspettassero. Non solo Donald Trump è tornato alla riscossa, ma le classi dirigenti internazionali e quella statunitense hanno per lo più preferito la via dell’apeasement – della pacificazione – a quella dello scontro, finora con scarsi risultati.
Con il nuovo anno gli Stati Uniti continueranno a essere al centro dell’attenzione, sia per i mondiali di calcio di giugno e luglio (organizzati insieme a Canada e Messico, ampiamente emarginati dal “mondiale Maga” da Trump e dal presidente della Fifa Gianni Infantino), sia per le elezioni di metà mandato di novembre.
I risultati di questa tornata elettorale avranno importanti conseguenze politiche che vanno ben oltre gli Stati Uniti, Europa compresa, come ha reso ben chiaro la Strategia di sicurezza nazionale del 2025, pubblicata di recente.
Gli Usa sospesi alle elezioni di midterm
Molti ormai, riferendosi agli Stati Uniti di Trump, parlano di un paese “autoritario” se non “fascista”, ma la situazione è complessa, e in continua evoluzione. Lo si è visto, per esempio, con le proteste del movimento No Kings contro la deriva autoritaria del governo: sono state tra le manifestazioni più imponenti della storia statunitense, eppure non hanno subìto repressione o violenza da parte delle autorità. Nonostante i tentativi dell’amministrazione Trump, gli Usa sono ancora una democrazia liberale, imperfetta e in crisi, anche se con un governo chiaramente autoritario.
Anche se le elezioni di metà mandato non potranno cambiare radicalmente la questione, potrebbero indebolire significativamente il potere dell’amministrazione e, si spera, infondere un po’ di coraggio nel mondo accademico, economico, politico e dell’informazione.
Finora Trump ha governato soprattutto usando gli executive order (decreti), con l’aiuto della maggioranza repubblicana al Congresso, che ha volontariamente abdicato alle sue prerogative costituzionali per paura di una minaccia diretta del presidente o della violenza dei suoi sostenitori.
Se i Democratici dovessero ottenere la maggioranza alla camera e/o al senato potrebbero abrogare, e per lo meno rallentare, gli ordini esecutivi e rendere Trump un presidente molto più debole per il resto del suo mandato. Soprattutto, la riconquista del Congresso darebbe al Partito democratico la possibilità di garantire che le elezioni del 2028 siano ancora sostanzialmente libere e regolari. E magari potrebbe mandare un messaggio chiaro alle varie élite, facendo loro capire che Trump non è la voce del popolo e che è possibile opporsi e resistergli con successo.
Naturalmente dovrebbero già saperlo, perché l’uno dopo l’altro i sondaggi stanno rivelando che Trump e le sue politiche sono estremamente impopolari negli Stati Uniti (e altrove). Da alcuni mesi il gradimento del presidente è disastroso, attestandosi al 36 per cento, anche se il dato rimane alto tra gli elettori repubblicani (dal 91 per cento del gennaio 2025 all’84 per cento dello scorso novembre).
Anche i suoi decreti, così numerosi da non avere precedenti, sono per lo più impopolari, e solo leggermente popolari tra i repubblicani. Sorprendentemente, anche per quanto riguarda il tema di punta delle sue politiche, l’immigrazione, il suo indice di gradimento è basso. Particolarmente importante per le elezioni di metà mandato è il fatto che il consenso di Trump sulla gestione dell’economia ultimamente è sceso ai minimi storici.
Quest’impopolarità è apparsa in modo lampante in tutte le elezioni che si sono tenute negli Stati Uniti nel 2025. Nonostante il Partito democratico (fatto sconcertante) sia ancora meno popolare di quello repubblicano, i suoi candidati hanno ottenuto ottimi risultati nella più importante giornata elettorale del 2025, il 4 novembre, con vittorie notevoli nel New Jersey, a New York e in Virginia, tra le altre.
Questi successi non si limitano alle aree più progressiste del paese. All’inizio di dicembre un democratico ha vinto un seggio nella città dove vivo, Athens, in Georgia, in una circoscrizione appositamente ridisegnata per blindare il risultato a favore dei Repubblicani.
È stato il venticinquesimo seggio conquistato dai Democratici a livello nazionale nel 2025. Inoltre, nelle 64 elezioni statali che si sono tenute quest’anno in media i candidati democratici hanno riguadagnato un 13 per cento di voti rispetto alle presidenziali del 2024.
In Europa, tutti gli occhi su Budapest
Chiaramente le elezioni di metà mandato sono cruciali per la democrazia statunitense e probabilmente stabiliranno se il paese rimarrà democratico nel prossimo futuro, ma, come dicevo, le ripercussioni si avvertiranno in tutto il mondo, a cominciare dall’Europa.
Questo è risultato chiarissimo con la pubblicazione della Strategia di sicurezza nazionale del 2025, che nella parte sull’Europa contiene un attacco frontale all’Unione europea, alla democrazia liberale e al multiculturalismo del continente: intrisa di ideologia di estrema destra e teorie del complotto (come la cosiddetta “grande sostituzione”), l’amministrazione Trump si pone l’obiettivo di “promuovere la grandezza europea... coltivando la resistenza all’attuale traiettoria dell’Europa all’interno delle nazioni europee” e di “consolidare le sane nazioni [sic] dell’Europa centrale, orientale e meridionale”.
Considerato che il documento afferma che “la crescente influenza dei partiti patriottici europei è in effetti motivo di grande ottimismo”, non c’è dubbio su quali siano le forze che l’amministrazione Trump considera sue alleate in Europa.
Il primo e più grande test di questa nuova politica estera interventista degli Stati Uniti saranno le elezioni legislative ungheresi del 12 aprile. Per la prima volta da quando ha riconquistato il potere e trasformato il paese in un regime semi autoritario, Viktor Orbán si trova ad affrontare uno sfidante credibile.
Tisza, il nuovo movimento dell’eurodeputato ed ex compagno di partito di Orbán Péter Magyar, ha un vantaggio a due cifre nei sondaggi e questo rende palesemente molto nervoso il premier ungherese. La sua rete propagandistica sta conducendo un’elaborata campagna denigratoria, mentre il suo governo ha chiesto (senza successo) al parlamento europeo di revocare l’immunità parlamentare di Magyar.
Non c’è dubbio che Trump voglia che Orbán rimanga al potere. Anzi, in una bozza della Strategia di sicurezza nazionale fatta trapelare alla stampa si cita esplicitamente l’Ungheria come uno dei quattro paesi con cui “lavorare di più... con l’obiettivo di allontanarli” dall’Unione europea (gli altri tre sono Austria, Italia e Polonia). Anche se il documento rimane vago sul modo in cui gli Stati Uniti puntano a raggiungere questo obiettivo, possiamo aspettarci come minimo un certo grado d’interferenza di Washington nelle elezioni ungheresi, magari con un sostegno finanziario come quello offerto al populista Javier Milei in Argentina.
Dovremo anche aspettarci interferenze russe a favore di Orbán, la voce più fedele al Cremlino all’interno dell’Unione, probabilmente attraverso campagne di disinformazione online. Magyar ha già accusato la Russia d’interferenze, un timore diffuso tra la maggioranza degli ungheresi.
Come risponderà questa volta l’Unione europea? Nell’ultimo decennio si è limitata a riconoscere che in Ungheria le elezioni sono state “libere ma non regolari”, dicendo però di non essere in grado di fare alcunché. Alle precedenti elezioni Orbán ha giocato su un terreno impari. Le cose potrebbero cambiare ora che Magyar minaccia la cleptocrazia del primo ministro ungherese e dei suoi sodali (compresa la sua famiglia).
Alcune voci sembrano indicare che Orbán voglia approdare alla presidenza del paese, dopo aver trasformato l’Ungheria in un sistema presidenziale (come ha fatto Recep Tayyip Erdoğan in Turchia). Il governo ungherese ha smentito queste voci, ma il parlamento ha già approvato una proposta di legge per “rafforzare” la presidenza, imponendo una maggioranza di due terzi (invece che una semplice) per destituire il capo dello stato.
Se il 2026 dovrà essere un anno migliore per la democrazia (europea) questa svolta dovrà arrivare dagli ungheresi e dagli statunitensi, che hanno la possibilità di infliggere un duro colpo ai propri leader antidemocratici
Ma anche se la Fidesz perdesse le elezioni e Orbán accettasse la sconfitta – due grossi “se” considerata la sua reazione alla sconfitta elettorale del 2002 – continuerebbero ad avere un potere notevole nel paese (molto di più rispetto al partito Legge e giustizia, Pis, in Polonia).
Negli ultimi quindici anni Orbán ha nominato suoi fedelissimi in quasi tutte le istituzioni statali. Si tratta di persone che in molti casi possono essere rimosse dal loro incarico solo da una maggioranza qualificata. A questo si aggiunge il fatto che l’Unione europea ha diversi piccoli Orbán al potere in altri paesi, come il primo ministro slovacco Robert Fico, quello ceco Andrej Babiš e il presidente polacco Karol Nawrocki, tutti apertamente sostenuti da Orbán nelle rispettive campagne elettorali. Nessuno di loro è fermamente euroscettico o filorusso come Orbán, né ha la stessa forza sul piano interno, ma tutti continueranno a rallentare e indebolire importanti politiche comunitarie in materia di politica estera (soprattutto su Russia e Ucraina), sui diritti delle minoranze e sullo stato di diritto.
In questi tempi drammatici la “bolla di Bruxelles”, come vengono soprannominate le persone che gravitano intorno alle istituzioni europee, torna sempre alla famosa affermazione del “padre fondatore” Jean Monnet secondo cui “l’Europa si farà nelle crisi”. Questo spiega perché hanno sottovalutato Trump, mentre alcuni fra i più convinti europeisti addirittura hanno sperato in una sua vittoria e altri ci hanno “semplicemente” visto un “risvolto positivo” per l’Europa.
Ma in un anno in cui il segretario generale della Nato ha esplicitamente messo in guardia l’Europa su un attacco russo entro cinque anni e gli Stati Uniti da alleato chiave sono diventati un importante avversario, più che rafforzarsi l'Unione si è divisa.
La presunta donna più potente del mondo, Ursula von der Leyen, è stata occupata a respingere gli attacchi di altri pesi massimi europei, ad affrontare scandali di corruzione e voti di sfiducia al parlamento europeo. Nell’arco di un anno è passata dall’essere la “Regina Ursula” a quella di “volto della debolezza dell’Unione europea”.
In breve, nonostante quello che forse è il contesto internazionale più ostile da quando è nata, l’Europa non ha imparato “a reggersi sulle proprie gambe”. Anzi, per lo più ha temporeggiato e ha adulato Trump, un approccio portato all’estremo dal segretario generale della Nato, Mark Rutte, che, con un’espressione tristemente nota, ha chiamato Trump “paparino”, con grande piacere del presidente statunitense. Tuttavia, temporeggiare è una strategia inutile se non hai un piano per il futuro. Per lo più ritarda l’inevitabile, come stiamo vedendo purtroppo nel caso dell’Ucraina, sempre più alle prese con una proposta statunitense favorevole alla Russia che ignora ed estromette completamente l’Europa.
Forse a questo punto vi aspetterete un finale ottimistico. La tesi per cui l’Europa ha finalmente imparato la lezione e ribalterà completamente la situazione. Purtroppo non vedo segnali di una svolta in questo senso. Tralasciando il fatto che ci sono tutt’al più prove empiriche contrastanti riguardo alla tesi di Monnet secondo cui l’Europa dà il meglio di sé in tempo di crisi, il continente è più diviso e isolato che mai. Non solo l’estrema destra rappresenta una forza importante nella maggior parte dei paesi europei e a tutti i livelli dell’Unione europea, ma il Partito popolare europeo (Ppe, conservatori) è sempre più schierato con lei al parlamento europeo, o minaccia di collaborare con lei per trascinare verso destra i gruppi centristi.
Inoltre, i grandi paesi europei hanno tutti governi deboli, nella maggior parte dei casi preoccupati di sopravvivere agli scontri politici interni (come in Francia, Germania, Polonia e Regno Unito). Per giunta, l’Unione è alle prese con quello che è stato definito lo “scandalo della frode diplomatica”, che potrebbe causare la caduta di Von der Leyen e quindi catapultare il continente in una crisi totale.
Insomma, se il 2026 dovrà essere un anno migliore per la democrazia (europea) questa svolta dovrà arrivare dagli ungheresi e dagli statunitensi, che hanno la possibilità di infliggere un duro colpo ai propri leader antidemocratici. Forse allora i leader politici in Europa e negli Stati Uniti potranno finalmente e realmente unirsi nella battaglia contro l’estrema destra, non solo a parole ma anche nei fatti.
Traduzione di Francesco De Lellis per Internazionale
Ti piace quello che facciamo?
Contribuisci a far vivere un giornalismo europeo e multilingue, in accesso libero e senza pubblicità. Il tuo dono, puntuale o regolare, garantisce l’indipendenza della nostra redazione. Grazie!