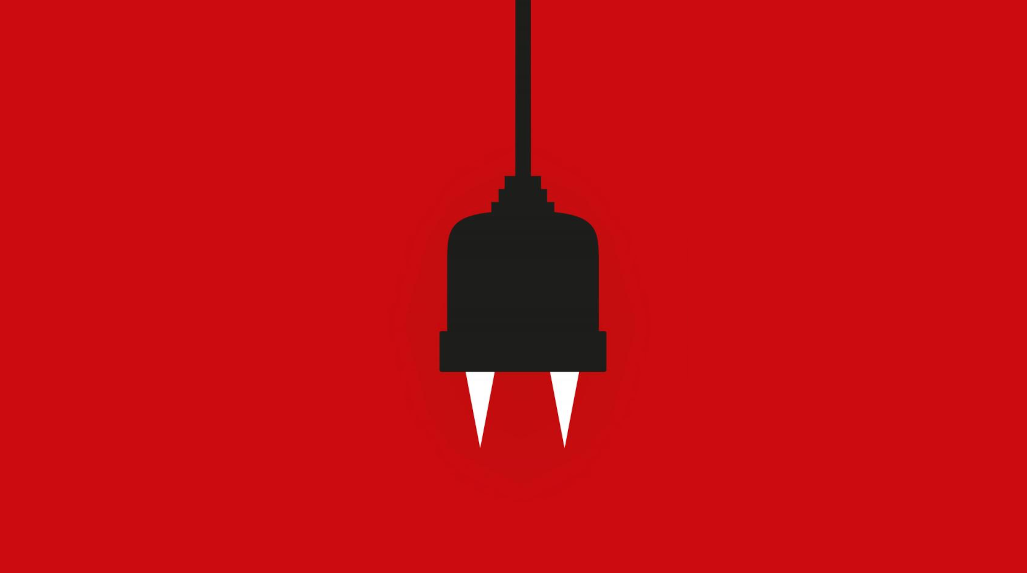Andrea* racconta che suo figlio è fortunato perché va a scuola, dove c’è il riscaldamento. Ma lei, che a 48 anni si ritrova in pensione anticipata, non ha la stessa fortuna: “Rimango a casa tutto il giorno, quindi ho sempre freddo”. Come spiega Boris Kingma, esperto dell’Organizzazione olandese per la ricerca scientifica applicata, vivere in un ambiente freddo comporta svariati rischi per la salute: “I vestiti ci possono proteggere dal freddo ma se l’ambiente domestico non è riscaldato, il corpo non è in grado di riprendersi dallo stress causato da un’esposizione prolungata alle basse temperature.”
Chi vive in ambienti freddi e umidi è esposto a un rischio più elevato di sviluppare disturbi mentali, malattie cardiovascolari (come l’infarto) e malattie respiratorie croniche. Tutto questo può portare all’incapacità di lavorare, a una riduzione del generale senso di benessere e persino a una morte prematura.
“L’impossibilità di riscaldare gli ambienti domestici è un problema che deve essere preso più seriamente”, sostiene Kingma, e bisogna farlo “non solo per la salute di milioni di persone ma, prima o poi, anche per l’economia di un singolo paese o dell’intera Europa”.
In quasi tutti i paesi dell’Ue, inclusa la Germania (dove 5,2 milioni di persone non si possono permettere di pagare il riscaldamento), il tasso delle persone colpite da questo problema è aumentato dal 2021, almeno secondo i dati risalenti al 2023. Per la Germania sono invece già disponibili i dati per il 2024 che mostrano come a essere interessato dal fenomeno sia il 6,2 percento della popolazione. Pur rappresentando un calo rispetto al 2023, il dato rimane nettamente superiore al periodo precedente alla crisi energetica (nel 2021 era al 3,3 percento).
In un sondaggio condotto a livello europeo da Eurostat, ai partecipanti veniva chiesto se la propria famiglia potesse permettersi di riscaldare adeguatamente la propria casa. Non veniva indicata una temperatura precisa, quindi le risposte erano basate su valutazioni soggettive. In generale, il problema riguarda sia chi riesce a riscaldare la propria casa, ma in modo insufficiente, sia chi proprio non può farlo. L’Associazione tedesca degli affittuari e l’Agenzia federale tedesca per l’ambiente consigliano di mantenere una temperatura minima di 20 gradi negli ambienti domestici.
Abbiamo parlato con alcune delle milioni di persone colpite e le loro storie sono allarmanti: molti raccontano che, per paura della prossima bolletta, preferiscono stare al freddo e che la temperatura nelle loro case si aggira intorno ai 10-15 gradi. Altri dicono di essere stati costretti a ridurre la spesa di beni alimentari per potersi permettere di accendere un po’ il riscaldamento. Tra le conseguenze di questo fenomeno non ci sono solo uno stress fisico e psicologico ma anche una condizione di isolamento, come riportano alcuni di loro.
È una fredda giornata di gennaio in un paesino vicino a Kassel, nella Germania nord-orientale, e Andrea è rannicchiata sul divano con indosso dei leggings termici e un maglione di lana, ai piedi porta due paia di calzini. “Vieni qua tesoro” dice affettuosamente Andrea al figlio undicenne Ben*, impegnato a giocare al cellulare, poi comincia a raccontare la loro situazione. “Il momento peggiore è la mattina” quando la donna apre le finestre per cambiare l’aria ed evitare che si formi la muffa mentre si veste il più velocemente possibile. La doccia può farla solo una o due volte a settimana ma almeno con il lusso dell’acqua calda.
Andrea ha una malattia cronica, per questo ha potuto beneficiare della pensione anticipata, come conferma una lettera dell’ufficio di previdenza sociale. La donna soffre di acne inversa, una malattia che causa la formazione ripetuta di infiammazioni sottocutanee molto dolorose e che richiedono interventi chirurgici.
Circa 47 milioni di persone in tutta l’Ue, Svizzera e Norvegia – pari al 10,2 percento del totale – non sono riuscite a riscaldare sufficientemente le loro abitazioni durante lo scorso inverno. Questa percentuale è aumentata sensibilmente a partire dal 2021, quando le persone colpite erano circa 31 milioni, ed è particolarmente elevata in alcune delle regioni più miti d’Europa: Spagna, Grecia, Portogallo, Bulgaria e Italia, a cui si aggiunge anche la Lituania.
“Povertà energetica” in Europa
Perché così tante persone in Europa – con picchi che in alcune regioni sfiorano il 30 percento – faticano a riscaldare adeguatamente le proprie case?
Secondo gli esperti, i fattori che contribuiscono maggiormente alla cosiddetta “povertà energetica” sono tre e stanno causando diversi problemi a livello europeo: edifici non ristrutturati, costi elevati dell’energia e redditi bassi . Sebbene in Europa i prezzi dell’energia si siano stabilizzati, restano comunque molto alti: nel 2024 il costo del gas naturale per le famiglie è quasi raddoppiato rispetto al 2020. Dopo l’aumento dei prezzi dovuto alla maggiore domanda di energia post-pandemia, la crisi energetica ha subito un’ulteriore accelerazione a causa dell’invasione russa dell’Ucraina a febbraio 2022. Anche i beni alimentari e gli alloggi sono diventati più costosi, mentre gli stipendi reali nell’Ue sono diminuiti dell’1,1 percento rispetto al 2019, come indicato in un rapporto sul mercato del lavoro pubblicato dalla Commissione europea nel 2024.
“Il problema è che più spendo per il riscaldamento, meno posso spendere per altro” dice Andrea. “Fare la spesa è diventato molto costoso”, continua la donna, elencando a memoria alcuni prezzi: un pacco di avena sottomarca costa 69 centesimi, 20 in più rispetto al passato, mentre una confezione da tre peperoni costa 2,49 euro. Andrea racconta che preferisce comprare i prodotti in sconto e che, in generale, per non sprecare nulla acquista solo lo stretto necessario.
Appena Ben esce dalla stanza, Andrea mi confida di sentirsi molto sola: “viviamo una vita isolata”, racconta, e mentre prima usciva volentieri a bere un caffè con gli amici, adesso non le è più possibile. Nonostante Ben ami molto andare al cinema, ora se lo possono permettere solo un paio di volte all’anno, e senza popcorn. Il figlio ha smesso anche di giocare a calcio: le trasferte, le scarpe e la divisa costavano semplicemente troppo. Mamma e figlio devono contare ogni centesimo e cercano di risparmiare ogni volta che ne hanno la possibilità.
L’aumento del costo della vita in Europa è una delle maggiori preoccupazioni tra i cittadini dell’Ue. “Le persone sono frustrate e questo può provocare insoddisfazione politica, mancanza di fiducia verso i partiti e, da ultimo, instabilità” afferma Aravinda Guntupalli, docente di salute pubblica all’università di Aberdeen. La crisi legata al costo della vita ha già scatenato diverse proteste in alcuni paesi.
Come riuscire a impedire che le persone muoiano di freddo sta diventando una questione sempre più urgente. Tuttavia, sono sorte alcune controversie politiche circa quale sia la giusta strada da percorrere, e ora l’Europa si trova anche a dover prevenire l’insorgenza di conflitti sociali.
Non è che i governi stiano necessariamente ignorando il problema: in Germania, misure per contrastare l’aumento dei prezzi e favorire la ripresa post-pandemia sono già costate allo stato diversi miliardi di euro, almeno secondo il Ministero federale per gli affari economici. Le misure annunciate a fine 2022 dal cancelliere tedesco Olaf Scholz includevano un abbassamento dei prezzi dell’energia, sovvenzioni sul prezzo del riscaldamento e una riduzione dell’Iva sul gas. “Per riuscire ad alleviare il carico finanziario nel breve periodo sono state necessarie ingenti somme di denaro” ha detto Florian Munder della Federazione delle organizzazioni dei consumatori tedeschi. La maggior parte di queste misure è però scaduta alla fine del 2023.
Secondo alcune stime del Consiglio tedesco di esperti economici, nonostante il rallentamento forzato dell’aumento dei prezzi dell’energia abbia contribuito a rallentare anche l’inflazione, chi non si può permettere di pagare il riscaldamento oggi si trova di fronte a un problema: le misure di sostegno sono più limitate rispetto al 2022 ma i prezzi continuano a essere elevati.
Anche le organizzazioni umanitarie stanno subendo gli effetti di questa crisi. “Al momento non abbiamo un piano a lungo termine per le nostre attività e i nostri utenti” afferma Maike Staufenbiel, un’operatrice sociale presso il Servizio sociale cattolico di Hamm che fornisce supporto a chi si trova indebitato. Maike è sconcertata dalla scarsa disponibilità di assistenza, dovuta a limitazioni di tempo e budget: “Il fatto è che siamo dipendenti dai sussidi finanziari. Ma alla fine, a essere affrontati sono solo i sintomi e non le cause”. Secondo la sua esperienza, a essere maggiormente colpite dal problema sono le persone impiegate nei settori con i salari più bassi, quelle che hanno un contratto part time, che soffrono di malattie croniche o i genitori single.
Già nel corso di quest’anno, il prezzo del gas – utilizzato dalla maggior parte della popolazione tedesca per il riscaldamento – è destinato a salire a causa dell’aumento delle tariffe di rete. Ci saranno infatti aumenti della tassazione sul gas e sul gasolio da riscaldamento: 55 euro per ogni tonnellata di CO2, rispetto agli attuali 45 euro.
Per chi non si può permettere l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, il costo del riscaldamento probabilmente continuerà a salire nei prossimi anni. A partire dal 2027, nell’ambito del Green Deal, verrà introdotta in tutta l’Ue una tassa sulle emissioni di gas serra (chiamata carbon pricing o fissazione del prezzo del carbonio) prodotte dal riscaldamento e dal rifornimento dei veicoli. Non a caso, l’energia utilizzata negli edifici contribuisce a ben il 36 per cento di tutte le emissioni generate nell’Ue.
Il Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (ETS2) dovrebbe sostituire quello attualmente in vigore in Germania e introdurre, anche nei paesi membri che non l’hanno ancora adottata, una tassa sulle emissioni prodotte dai sistemi di riscaldamento e dal settore dei trasporti. Un’analisi condotta dell’Agenzia federale per l’ambiente, basata su diversi studi, ha concluso che entro il 2030 sarà possibile fissare il prezzo del carbonio tra i cento e le diverse centinaia di euro.
A differenza degli aumenti improvvisi causati dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, questo tipo di innalzamento dei prezzi è prevedibile. Nel frattempo, gli stati dell’Ue dovrebbero lavorare per integrare l’ETS2 nella loro legislazione nazionale e per sviluppare i propri Fondi sociali per il clima. Questi ultimi consentiranno agli stati, a partire dal 2026, di accedere a fondi europei derivanti dai profitti delle tasse sulle emissioni e di ridistribuirli tra i cittadini. L’obiettivo principale è evitare che i prezzi elevati dell’energia colpiscano in modo sproporzionato le fasce più povere della popolazione.
Nell'estate del 2024, tuttavia, la Commissione europea ha avviato una prima fase della procedura di infrazione contro la Germania e altri 25 stati membri per non aver messo in atto le misure richieste.
Al momento rimane poco chiaro quale politica climatica verrà adottata dal prossimo governo tedesco, così come si svilupperà il supporto al Green Deal a livello europeo. Il patto – che fu adottato nel 2019 dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, di orientamento conservatore – pone come obiettivo il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050.
In un momento caratterizzato da un elevato costo della vita, scegliere di non attutire l’impatto della tassa sulle emissioni con misure di sostegno comporta conseguenze significative sul piano sociale e politico. Chi può permettersi di ristrutturare o di installare sistemi di energia rinnovabile sarà sottoposto a un impatto minore, mentre le persone più povere o che vivono in affitto dovranno destinare una parte maggiore dei loro stipendi a coprire i costi del riscaldamento e rimarranno dipendenti dalla CO2. In generale, in tutta Europa si stanno tenendo molte discussioni intorno alla tassa sulle emissioni.
“Al momento i gruppi più conservatori e di destra al Parlamento europeo, alcuni stati membri e il mondo dell’impreditoria in generale stanno tentando di annullare gli sforzi per il clima” afferma Michael Bloss, europarlamentare dei Verdi. “Sarebbe saggio iniziare a lavorare subito alla creazione di programmi per le potenziali entrate, in modo da poter erogare il denaro già dal 1° gennaio 2026. Diversamente si corre il rischio che dal 2027 l’ETS2 si trasformi in una trappola sociale”.
Anche in Germania i preparativi sono fermi. Inizialmente, il programma Klimageld (soldi per il clima) – che prevede una somma una tantum erogata direttamente ai cittadini e che era stato annunciato dal governo federale uscente nel suo accordo di coalizione – è fallito per la mancanza di una soluzione tecnica per trasferire i soldi alla popolazione. Il problema è stato nel frattempo risolto, ma starà al prossimo governo decidere se questi soldi verranno effettivamente erogati. La Cdu ha in programma una riduzione iniziale dei prezzi dell’elettricità, mentre i pagamenti diretti potrebbero avvenire in un secondo momento, almeno secondo quanto dichiarato da un portavoce del partito per le politiche climatiche.
In Austria sono già stati avviati oltre 60 progetti grazie alle entrate nazionali derivanti dalla tassa sulle emissioni. Per esempio, una parte di queste entrate viene destinata al cosiddetto Klimabonus (bonus per il clima), un assegno diretto di cui beneficiano tutti i cittadini, bambini compresi.
Dal 2022, tutte le persone che vivono legalmente nel paese da più di sei mesi hanno ricevuto pagamenti automatici, scaglionati in base al gruppo sociale di appartenenza. In particolare, questa misura ha l’obiettivo di offrire alle persone socialmente svantaggiate, come quelle con i redditi più bassi o che vivono in aree con scarse infrastrutture, la possibilità di investire in pompe di calore, pannelli solari o altri sistemi di riscaldamento basati su fonti rinnovabili.
Il governo afferma che il progetto ha l’obiettivo di “incentivare le persone a scegliere alternative più ecologiche”, ma al momento l’importo annuale erogato ai cittadini ammonta a 145 euro, a cui può aggiungersi, se previsto, un compenso regionale fino a ulteriori 145 euro. Tuttavia, non esiste un sistema di monitoraggio che verifichi come i beneficiari scelgono di utilizzare questi fondi.
Lo stesso vale anche per i singoli paesi che dovrebbero destinare i ricavi dell'ETS a investimenti in misure per il clima. Tuttavia, “al momento non esiste un sistema di controllo, semplicemente si spera che i paesi rispettino il piano” afferma l’europarlamentare Bloss.
Gli esperti concordano che una misura fondamentale per la salvaguardia del clima e della popolazione siano le ristrutturazioni: le abitazioni a zero emissioni di CO2 sono infatti esenti dalla relativa tassa. Inoltre, una riduzione complessiva dei certificati di CO2 richiesti contribuisce ad abbassare i costi anche per chi utilizza ancora i combustibili fossili per il riscaldamento.
L’accordo europeo sull’efficienza energetica degli edifici prevede un notevole aumento delle ristrutturazioni, rendendo perciò necessari interventi significativi in Germania, dove molti edifici richiedono lavori di ristrutturazione. Secondo lo studio Climate neutrality not before 2075+?, pubblicato dalla società di consulenza S&B Strategy di Monaco di Baviera, questo rischia di impedire al paese di raggiungere gli obiettivi del Green Deal. Già lo scorso anno, l’organizzazione per la protezione dell’ambiente BUND e l’Associazione tedesca degli affittuari avevano criticato questi ritardi.
Secondo Sibylle Braugardt dell’Oko-Institut di Friburgo, in Germania esistono numerosi programmi di sostegno finanziario per incentivare le ristrutturazioni orientate a una maggiore efficienza energetica e alla sostituzione dei sistemi di riscaldamento con impianti più sostenibili. Tuttavia, i maggiori beneficiari di queste agevolazioni sono le famiglie ad alto reddito: “È problematico se a potersi permettere di ristrutturare e installare pompe di calore, ottenendo così un’esenzione dalla tassa sulle emissioni, sono solo i proprietari di immobili e non chi vive in affitto.”
Altrettanto cruciale è l’isolamento termico delle abitazioni: “Se l’edificio non è ben isolato, il calore si disperde. In questo caso, anche sussidi permanenti volti a diminuire i costi del riscaldamento risulterebbero inutili sul lungo periodo” afferma Susanne Nies, che oltre a essere project manager per l’energia e l’informazione presso l’Helmholtz Centre si è anche occupata di povertà energetica a Bruxelles e dirige il progetto Green Deal Ukraine. Soprattutto in Europa orientale, molti edifici non sono adeguatamente isolati e, nei paesi più caldi, gli edifici sono spesso sprovvisti dell’infrastruttura necessaria. “Elettricità e riscaldamento non dovrebbero rappresentare un problema sociale."
👉 L'articolo originale su Correctiv
Ti piace quello che facciamo?
Contribuisci a far vivere un giornalismo europeo e multilingue, in accesso libero e senza pubblicità. La tua donazione, puntuale o regolare, garantisce l’indipendenza della nostra redazione. Grazie!