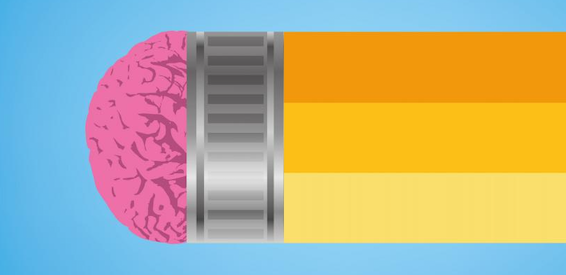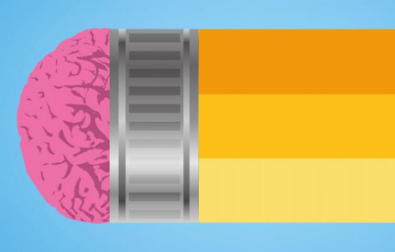Accanto alla superstrada R107 del Kosovo, in un paesaggio fatto di autolavaggi e negozi di marmo dove aleggia odore di aceto, il futuro è racchiuso in una cooperativa di produzione di ajvar, la salsa di peperoni rossi arrostiti. Questa fabbrica di conserve si trova a Krushë e Madhe, un villaggio di agricoltori nella parte occidentale del Kosovo, ed è stata avviata da Fahrije Hoti e altre vedove come lei, con il sostegno di diverse organizzazioni internazionali.
Con oltre 140 vedove di guerra in un comune di appena 3mila abitanti, il luogo è conosciuto come il villaggio delle vedove di guerra.
Tre donne vestite di nero, una delle quali al volante, scendono da una macchina a pochi metri dalla fabbrica. Spiegano che ci sono molte vedove nel villaggio, “e in quello accanto”. Tra il febbraio 1998 e il dicembre 2000, oltre 13mila persone sono state uccise o sono scomparse nella guerra del Kosovo, quando il conflitto etnico tra serbi e albanesi-kosovari si è inasprito nell'ultima fase della disgregazione della Jugoslavia.
Di queste, più di diecimila erano albanesi del Kosovo, circa duemila i serbi e il resto rom e bosniaci, secondo i dati del Centro per i diritti umani del Kosovo. La violenza sessuale è stata utilizzata estesamente come arma di guerra. Cosa si sarebbe potuto fare di più per le sopravvissute e quali lezioni si possono trarre per altri conflitti in atto?
Precarietà, traumi e pregiudizi
“Ne abbiamo passate così tante, e sono rimasta sola con sette orfani”, dice con voce tremante Meradije Ramadani, residente a Krushë e Madhe. “Poi siamo stati costretti a fuggire, a causa dell'occupazione serba, che ha distrutto noi, le nostre case e tutto ciò che avevamo”, si infervora. “Grazie a Dio, l'Albania ci ha aperto le porte”, continua. “Poi siamo tornati”.

Sono passati 26 anni da quando il marito di Meradije Ramadani è stato ucciso e 25 da quando è tornata in Kosovo: “Quando siamo tornati, non c’era neanche una costruzione in piedi, era tutto raso al suolo, bruciato, ridotto in cenere, completamente distrutto”, ricorda. Quel primo anno, racconta, hanno dormito all'aperto, “in tende, sotto teloni di plastica, non avevamo una casa”.
Nonostante questo, Ramadani ha continuato a far andare le figlie a scuola: “Sia io che mio marito abbiamo sempre voluto che studiassero e diventassero qualcuno”, precisa. Oggi dice di sentirsi orgogliosa: “Hanno studiato, si sono sposate e oggi sono nonna di 17 nipoti”, afferma. “E tutti i miei sette figli hanno un lavoro”.
La notte del 24 marzo 1999 la Nato lanciò una serie di bombardamenti contro le forze serbe. Era la prima volta che lo faceva senza un mandato dell'Onu e con la partecipazione di soldati tedeschi. Il giorno dopo, nel pomeriggio del 25 marzo 1999, i paramilitari e l'esercito serbo di occupazione entrarono a Krushë e Madhe e portarono via gli uomini, per rappresaglia.
“Maestro, maestro, maestro...”, recita Irfon Ramadani, indicando, uno dopo l'altro, i ritratti esposti nel museo del massacro di Krushë e Madhe. Ramadani aveva otto anni quando avvenne il massacro: “Separarono le donne da un lato e gli uomini e i bambini dall'altro, e li portarono via”, ricorda, mentre cammina per il museo, dove adesso fa la guida. Nelle vetrine ci sono lettere, vestiti, occhiali e libri degli abitanti assassinati. E uno zaino sporco di fango. “Anche in tempo di guerra non si separava mai dal suo zaino e dai suoi libri”, si legge nella didascalia che riporta le parole della madre di un ragazzo di 17 anni che voleva diventare medico.
Nell'estate del 1999, Hoti tornò al villaggio in rovina, da sola, con i suoi due figli, Sabina, una bambina di tre anni, e Drilon, un neonato. C'erano molte donne nella stessa situazione che dovevano affrontare una doppia sfida.
Da un lato, il lutto per la morte del marito; dall'altro, i pregiudizi sociali per aver occupato il posto riservato agli uomini. Hoti cominciò a vendere ajvar e miele e si organizzò con altre donne. Oggi la sua cooperativa impiega più di 60 vedove e la sua storia è arrivata al cinema, con il film Zgjoi (Arnia).

Tuttavia, la maggior parte di loro non è riuscita ad avviare un'attività.
"La vita era estremamente dura, soprattutto per le vedove, che spesso si lamentavano dell'ipocrisia sociale: da un lato erano messe su un piedistallo, celebrate come le vedove dei martiri, come responsabili della formazione della prossima generazione, ma al tempo stesso ricevevano pochissimo sostegno", ricorda a El Confidencial la professoressa Hanna Kienzler, antropologa e co-direttrice dell'ESRC Centre for Society and Mental Health del King's College di Londra, che si è trasferita a Krushë e Madhe tra il 2007 e il 2009 per studiare gli effetti della guerra sulla salute mentale delle donne sopravvissute a crudeltà estreme.
Da allora, Kienzler è tornata al villaggio ogni anno, “tranne durante la pandemia”, precisa. Kienzler afferma che, all'epoca, la pensione di reversibilità era di 62 euro. “Sai cosa si può comprare in Kosovo con quella cifra? Una bottiglia di olio da cucina costa 2 euro e un paio di pantaloni lo stesso che in Germania o in qualsiasi altro posto: fai tu i conti”, si indigna.
E con quella somma dovevano pagare per l'istruzione dei figli e, spesso, prendersi cura di altre persone a carico. “Il che generava nuovamente uno stress fortissimo”, precisa. Nel 2014, il governo kosovaro ha implementato un sistema di indennizzi per diversi gruppi di persone colpiti dalla guerra, che è stato aumentato nel 2025.
Alla precarietà e al trauma si sono aggiunte le aspettative sociali: “Le madri o i loro figli hanno dovuto imparare a guidare il trattore e, una volta finito il raccolto, le donne non potevano venderlo da sole al mercato, perché a quel tempo, semplicemente, non si faceva”, ricorda Kienzler. “Quindi, spesso, dovevano assumere parenti o vicini per vendere i loro peperoni”, aggiunge.
La maggior parte di loro non poteva nemmeno vivere da sola. Alcune donne hanno persino dovuto rinunciare ai propri figli. Per gli albanesi del Kosovo, come per altri popoli dei Balcani e del Caucaso meridionale, la famiglia è “patrilocale”, ovvero quando una coppia si sposa, ci si aspetta che marito e moglie si trasferiscano a casa dei genitori di lui e i discendenti sono considerati appartenenti alla famiglia paterna. Questo rende il sistema “organizzato secondo la linea paterna maschile” e i figli maschi sono necessari per perpetuare la discendenza, spiega un rapporto delle Nazioni Unite e World Vision.
Così, alcune vedove hanno dovuto tornare a casa dei loro genitori, mentre i loro figli venivano cresciuti dalle suocere e dalle cognate. Flora, rimasta vedova a 24 anni, ha raccontato a Balkan Insight di essere stata costretta dalla famiglia del marito a tornare dai suoi genitori senza sua figlia, che è cresciuta credendola una zia.

“Se una donna rimaneva vedova e voleva tornare a casa dei suoi genitori, nella maggior parte dei casi era costretta a lasciare i figli, quindi molte vedove continuavano a vivere con i suoceri”, spiega Kienzler. E se per i vedovi era normale trovare presto una nuova compagna, per le vedove risposarsi era ancora un tabù. Nel 2010 c'erano 5.052 vedove di guerra in Kosovo e solo 20 (0,4 per cento) avevano perso il diritto alla pensione di reversibilità perché si erano risposate.
Per questo motivo, e poiché la maggior parte di loro non aveva un sostegno economico a lungo termine, pochissime sono riuscite a costruirsi una propria attività, “ma questo non significa che non siano state incredibilmente forti”, afferma l'antropologa, che durante la videochiamata ha le lacrime agli occhi. Come molte altre donne, dice, Ramadani è riuscita a mandare le sue sei figlie all'università, “anche se, all'inizio, molti compaesani non l’hanno sostenuta”.
“Bisogna parlare per porre fine allo stigma”
E mentre lottavano contro le aspettative sociali, dentro erano consumate dalla vergogna, la sofferenza e i ricordi. Parlare del trauma non è stato facile. Nella sua ricerca, Kienzler lo definisce “il linguaggio dei sintomi”, riferendosi al fatto che, a volte, raccontare quegli orrori ad altre donne era così sconvolgente che bastava dire: “Me ne sono appena ricordata e ora ho mal di testa, mal di stomaco”, perché le altre capissero di cosa stavano parlando, visto che tutte avevano vissuto esperienze simili.
Vasfije Krasniqi aveva 16 anni quando, il 14 aprile 1999, fu rapita da un poliziotto serbo, portata in un altro villaggio, torturata e violentata da diversi uomini. Dice che quell'episodio le ha cambiato la vita per sempre. Vasfije è stata una delle prime persone che ha avuto il coraggio di riconoscere pubblicamente di aver subito violenza sessuale durante la guerra: “Voglio che il mondo capisca che la giustizia che arriva in ritardo è giustizia negata”, dice Krasniqi, categorica. Krasniqi sottolinea che le sopravvissute a violenze sessuali in tempo di guerra “hanno bisogno di sostegno immediato e a lungo termine, e non di decenni di silenzio”, e ricorda che i governi devono agire rapidamente per riconoscere le vittime, promuovere la tutela della salute mentale e processare i responsabili.
Krasniqi ritiene che le società devono cambiare il loro modo di guardare le sopravvissute: “Non dobbiamo impietosire nessuno e non ci portiamo addosso il marchio della vergogna, siamo testimoni della storia e il nostro coraggio può aiutare a prevenire future atrocità”. Quindi, “se la mia storia insegna qualcosa, è che la verità e la dignità sono potenti forme di giustizia, e che il silenzio protegge solo i responsabili, mai le persone superstiti”, aggiunge.
Quasi vent’anni dopo la fine della guerra, nel febbraio 2018, le autorità kosovare hanno stabilito una pensione di 230 euro per chi è sopravvissuto a episodi di violenza sessuale. Tuttavia, a causa dello stigma che comporta questa condizione, solo 1.870 persone avevano richiesto l’indennizzo nel 2023. Si stima che circa 20mila donne e uomini siano state vittime di violenza sessuale usata come arma di guerra.
Vedove e migranti dall’oggi al domani
Dall'altra parte del conflitto, si stima che circa 200mila civili di etnia serba e rom siano fuggiti nel 1999 dal Kosovo alla Serbia. Un rapporto di Human Rights Watch dell'agosto 1999 descriveva l'“ondata di rapimenti e omicidi di serbi” dalla metà di giugno di quell'anno, compreso il massacro di 14 contadini serbi, come ritorsione per le atrocità commesse dalle forze di sicurezza serbe prima dell’arrivo della NATO. Molti degli sfollati erano donne.
"Queste donne erano diventate vedove dall'oggi al domani e avevano dovuto fuggire immediatamente in Serbia in cerca di riparo per sé e per le loro famiglie – figli, genitori, parenti – quindi alla vedovanza si è aggiunta l’emigrazione verso il paese d’origine del loro gruppo etnico, dove in molti casi non sono state ben accolte”, spiega la sociologa serba Mirjana Bobić, coautrice dello studio “Sulle vedove o su un'ingiustizia sociale" (2020). Le vedove di guerra migranti si sono fatte carico del sostentamento economico della loro famiglia, “spesso lavorando nel commercio, nel settore delle pulizie, in falegnamerie, bar e pasticcerie”, spiega Bobić. Alcune erano anche malate.
Quindi, “poiché dallo stato non arrivava un effettivo sostegno, la maggior parte di loro dipendeva da parenti e amici fuggiti con loro”, precisa la sociologa serba. Lo stato non era pronto ad accogliere in così poco tempo tanti rifugiati provenienti dalla Croazia e dalla Bosnia-Erzegovina: oltre 600mila, secondo il censimento dei rifugiati effettuato dall'Unhcr. Inoltre, chi non lavorava non poteva contare sulla pensione dello stato serbo prima dei 45 anni. Pertanto, le uniche entrate erano sussidi o fondi concessi ai figli, a patto di poter dimostrare che il padre era morto o scomparso in guerra, spiega Bobić.
E “ciò significava tornare nei territori che avevano abbandonato, cercare i resti dei corpi e presentare le prove”.
Cambia il contesto, ma in ogni dopoguerra i meccanismi di sostegno sociale, economico e psicologico sono essenziali per affrontare sia il trauma che la precarietà. Solo in Ucraina, si stima che ci siano già decine di migliaia di vedove di guerra.
👉 L'articolo originale su El Confidencial
🤝 Questo articolo è stato realizzato nell'ambito del progetto PULSE, un'iniziativa europea a sostegno della collaborazione giornalistica internazionale. Nicole Corritore (Obct) ha contribuito alla sua realizzazione
Ti piace quello che facciamo?
Contribuisci a far vivere un giornalismo europeo e multilingue, in accesso libero e senza pubblicità. Il tuo dono, puntuale o regolare, garantisce l’indipendenza della nostra redazione. Grazie!