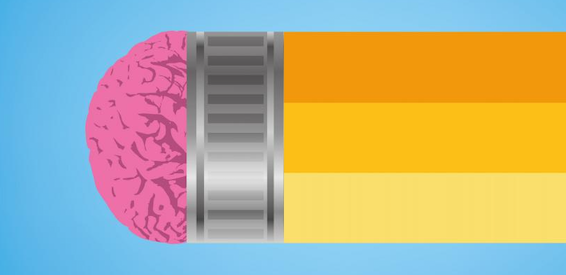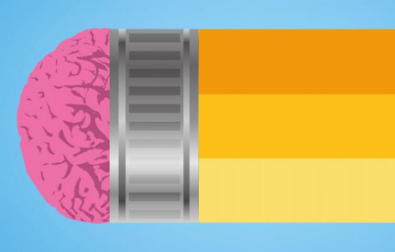“Sarebbe stato più logico che uno spagnolo andasse a vendere in Italia e non che venisse qui un italiano”. Con una camicia a fiori e occhiali spessi, Leonardo D’Errico, italiano residente in Spagna dagli anni Novanta, ripercorre la sua storia circondato dai campioni di olio e dai trofei di caccia che decorano le pareti del suo ufficio a Torredonjimeno (Jaén, Andalusia).
La sua storia coincide con quella del commercio dell’olio d’oliva: potente industria italiana che ha costruito un impero basato sulla produzione intensiva in Spagna, ma che ha visto quest’ultima arrivare pian piano a conquistare i vertici delle esportazioni mondiali.
D’Errico è un intermediario che mette in contatto commercianti e frantoi. L’Italia ha sempre avuto bisogno di olio da esportare, mentre la Spagna, che in condizioni normali produce circa la metà dell’olio d’oliva sul mercato mondiale, ne avanza. Questo squilibrio ha dato luogo a un rapporto di dipendenza in base al quale l’Italia compra, imbottiglia con sue etichette e rivende a un prezzo più alto grandi quantità di olio spagnolo. Si tratta di una parte consistente: circa la metà delle esportazioni spagnole finisce in Italia, che nella stragrande maggioranza dei casi le rivende, per lo meno sin dagli anni Novanta.
Oggi questo modello imprenditoriale sta diventando obsoleto: “Il nostro lavoro ha cominciato a diminuire perché i grandi gruppi spagnoli hanno un rapporto diretto con i produttori”, racconta D’Errico. Nel 2023 l’Italia si è accaparrata solo il 22 per cento delle vendite di olio d’oliva spagnolo, una cifra impensabile dieci anni fa, quando la percentuale si attestava ancora al 47 per cento. La filiera commerciale si è accorciata e la vendita di olio sfuso a poco prezzo destinato all’Italia sta lasciando il posto a quella di olio in bottiglia di qualità e valore superiore.
Ciononostante, il settore oleario spagnolo continua a parlare italiano. L’oro liquido andaluso inonda i mercati internazionali, ma con nomi come Pompeian, Carapelli o Bertolli. Il “made in Italy”, avverte Leonardo D’Errico, “è intoccabile”.
Il 40 per cento della produzione mondiale
Con 283 milioni di olivi, la Spagna domina il mercato globale dell’olio d’oliva: nella campagna 2021/22, l’ultima prima che la siccità affossasse il raccolto, i paese ha prodotto il 44 per cento dell’olio mondiale, garantendosi il 59 per cento delle vendite internazionali, secondo i dati del Consiglio oleicolo internazionale. Nello stesso periodo, l’Italia ha toccato appena quota 10 per cento di produzione e 20 per cento di esportazioni, con una differenza però: le sue vendite, pur essendo per la stragrande maggioranza di olio spagnolo, sono state del 41 per cento circa più redditizie, secondo Eurostat. Il marchio spagnolo vale ancora poco rispetto a quello italiano.
Carbonell si è scontrato con questa realtà all’inizio degli anni 2000: è sbarcato negli Stati Uniti con il gruppo Deoleo – che allora si chiamava SOS e aveva sede a Cordova – e si è lanciato alla conquista di un mercato in forte ascesa, ma monopolizzato dall’Italia. Non ha funzionato. Per gli americani, come per molti europei, l’olio è un prodotto italiano.
Le ragioni di questa associazione sono storiche. Come sostiene Teresa Pérez, amministratrice dell’Organizzazione interprofessionale dell’olio d’oliva spagnolo, “la Spagna era posizionata molto bene prima della Seconda guerra mondiale e della dittatura, ma poi è diventata un mercato chiuso, e l’immigrazione italiana si è fatta ambasciatrice dell’olio d’oliva”. L’isolamento spagnolo è coinciso poi con la creazione della Comunità economica europea, che nel 1957 ha liberalizzato il commercio fra gli stati membri e ha sovvenzionato la produzione agricola, compresi gli oliveti italiani. E intanto la Spagna doveva pagare i dazi per esportare nel resto d’Europa.
“Chi colpisce per primo, colpisce due volte”, riassume Rafael Pico, direttore generale dell’Associazione spagnola dell’industria e degli esportatori di olio d’oliva e olio di sansa (ASOLIVA), una frase che si sente negli uffici di tutto il settore. L’Italia è arrivata prima e ha colonizzato i mercati internazionali.
Tuttavia, la sua produzione, stagnante dagli anni Novanta, riesce a coprire appena la domanda interna, quindi l’Italia si vede costretta a rivolgersi al bacino del Mediterraneo per sostenere le esportazioni, che sono triplicate negli ultimi trent’anni. La Spagna è la fonte primaria delle importazioni italiane di olio (90 per cento); seguono poi Grecia, Tunisia, Portogallo, Turchia e Siria.
La produzione spagnola invece si è triplicata a partire dagli Novanta. L’ingresso nella Comunità economica europea nel 1986 ha favorito la modernizzazione e la competitività degli oliveti grazie agli aiuti della Politica agricola comune, ma anche grazie alla scelta di puntare su una coltivazione intensiva e irrigua. La conseguenza è stata che, se prima in Spagna si irrigavano meno di 100mila ettari di oliveti, nel 2023 si è arrivati a quasi 900mila e la produzione della provincia di Jaén, da sola, ha superato quella di tutta l’Italia.
“La Spagna ha fatto un grande lavoro sotto il profilo dell’agronomia, e l’Italia sotto quello commerciale. Noi ci siamo dedicati alla produzione di olio a basso costo, alla meccanizzazione e all’irrigazione di grandi campi”, racconta Rafael Gutiérrez, direttore delle operazioni all’ingrosso della cooperativa Dcoop, primo produttore al mondo di olio d’oliva. L’azienda, con sede ad Antequera (Malaga), esporta quasi la metà di quello che produce, soprattutto olio sfuso verso l’Italia. Ma Gutiérrez avverte: “Ci sono nomi italiani, non marchi italiani”.
La Spagna è la fonte primaria delle importazioni italiane di olio; seguono Grecia, Tunisia, Portogallo, Turchia e Siria
La stessa Dcoop è passata dall’essere un semplice produttore di olio sfuso a competere per la sua commercializzazione all’estero. Per questo ha “italianizzato” le proprie vendite con il marchio Pompeian, fondato da immigrati italiani nel 1906 a Baltimora: nel 2015 la cooperativa è entrata in società con i proprietari con lo scopo di vendere olio andaluso negli Stati Uniti con il proprio marchio e alla fine è diventato leader di mercato con una quota del 20 per cento. “Pompeian ha capito che doveva diventare più forte anche sul versante della produzione e adesso può contare su 75mila agricoltori in Andalusia. Non è un intermediario italiano che compra in tutto il mondo, e questo discorso ha fatto presa in America”, spiega il responsabile delle vendite all’ingrosso.
Un’operazione simile l’ha fatta Deoleo, leader mondiale nel settore dell’olio d’oliva, che pur essendo di proprietà del fondo di investimento britannico CVC Capital Partners dal 2014, mantiene la sua sede sociale in Spagna. Dopo il fiasco di Carbonell, ha cambiato strategia e ha sborsato parecchio per comprare i marchi italiani Minerva (2005), Friol (2006) e Bertolli (2008). Come risultato di queste acquisizioni, olio prodotto a Cordova viene commercializzato in tutto il mondo con nomi come Bertolli, Carapelli o Sasso senza nemmeno essere mai passato dall’Italia.
Secondo Rafael Pérez, responsabile della qualità di Deoleo, il gruppo ha “ribaltato la situazione”. “Compriamo fra il 70 e il 90 per cento del nostro olio in Spagna, utilizziamo marchi italiani e li distribuiamo nel resto del mondo”. In questo modo la Spagna è riuscita a imporsi nella commercializzazione dei marchi italiani e a sfruttarne il richiamo internazionale per incrementare le vendite, seppur a scapito dei marchi spagnoli”.
Grazie a questo cambio di strategia, dal 2014 la Spagna è leader indiscussa del mercato extraeuropeo e dal 2016 anche di quello degli Stati Uniti, che ormai sono il secondo maggior importatore del mondo e presto diventeranno il primo consumatore. In Messico e Asia, mercati emergenti in cui Spagna e Italia sono stati concorrenti alla pari, la Spagna monopolizza le vendite, con imprese come Deoleo (Cordova), Dcoop (Malaga), Sovena (Siviglia) e Acesur (Jaén) che sono le grandi protagoniste delle esportazioni di olio spagnolo.
“Questo risultato non si ottiene dall’oggi al domani: i guadagni sono stati investiti tutti in nuove piantagioni, impianti migliori e una più ampia distribuzione sui mercati. Abbiamo saputo investire, a differenza dell’Italia”, commenta Rafael Pico, direttore generale di ASOLIVA.
Ciononostante, un quarto delle esportazioni spagnole finisce ancora in Italia, fatto di cui Pico incolpa gli agricoltori e le cooperative: “La filosofia dell’industria si concentra sul futuro, sul margine di guadagno e sul marchio per creare una catena di valore per l’intero settore, ma agli agricoltori e alle cooperative non importa, pensano solo al presente”.
Cristóbal Cano, responsabile del settore dell’olio d’oliva dell’Unione dei piccoli agricoltori e allevatori, difende gli agricoltori sostenendo che “in realtà non vendono l’olio”, sono gli italiani a venire a comprare nei frantoi sfruttando la propria “posizione dominante” per fissare il prezzo. E contrattacca: “È l’industria ad avere una visione poco lungimirante, perché sfrutta i marchi italiani senza cercare alternative più vantaggiose per il nostro paese”.
Quantità e qualità
Con 1842 frantoi e circa 400mila olivicoltori, l’atomizzazione del settore è stato uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo dell’industria spagnola. All’estremo opposto della filiera, le aziende della grande distribuzione come Mercadona rappresentano tre quarti delle vendite e riescono a influenzare fortemente i prezzi alla fonte.
Il tessuto produttivo è costituito in gran parte da cooperative che raccolgono circa il 70 per cento della produzione, ma la filiera perde densità nella sua parte intermedia, quella della commercializzazione. L’esatto opposto di quanto succede in Italia. Per questo, per dare sfogo a una produzione che in genere copre il triplo del consumo nazionale, la Spagna si vede costretta a ricorrere alla vendita di olio sfuso, che rappresenta circa due terzi delle esportazioni.
“Se si guarda il business dal lato della produzione c’è un problema, perché quando produci tanto olio non sai cosa fare e finisci per regalarlo”, commenta Rafael Pérez. Per altri, invece, è “una fortuna che ci sia un mercato in deficit” come quello italiano che copre le necessità di vendita della Spagna. È di questo avviso il direttore generale della cooperativa sivigliana Oleoestepa, Álvaro Olavarría, che tuttavia preferisce diversificare l’attività: “L’olio sfuso è una commodity e dipendere solo da questo significa esporsi a notevoli rischi”.
Oleoestepa, che conta 7mila soci e lavora solo con olio extravergine di oliva, quest’anno ha dato la priorità al prodotto imbottigliato – più redditizio – anziché a quello sfuso, per la carenza di olive, e di conseguenza le vendite verso l’Italia sono state minime. Ma il suo direttore generale lo dice chiaramente: “Se il clima ci è favorevole, andremo sui mercati internazionali dell’olio sfuso come l’Italia”.
Scommette sulla qualità e il marchio autoctono anche Aires di Jaén, che esporta fra il 60 e il 70 per cento del raccolto da Jabalquinto, solo in bottiglia. Secondo Ichun Lin, responsabile delle esportazioni dell’azienda di Jaén, “la tua attività vale quanto vale il tuo marchio”, per questo è importante “dare un motivo valido per essere scelti e raccontare una storia dietro il prodotto. Se si produce solo olio sfuso, dal punto di vista strategico non si apporta alcun valore. Bisogna scommettere sul prodotto imbottigliato come ha fatto l’Italia cinquant’anni fa”, sostiene Lin.
Olio prodotto a Cordova viene commercializzato in tutto il mondo con nomi come Bertolli, Carapelli o Sasso
Al momento però la Spagna non sta vincendo la battaglia della qualità, come dimostra la differenza di prezzo o il numero di denominazioni di origine: l’Italia ne ha dodici più della Spagna. La varietà Picual è la più comune in Spagna e anche la più premiata al mondo, ma se si raccoglie oltre il mese di ottobre prende un gusto che in genere non piace all’estero. In Spagna, molti agricoltori lasciano maturare le olive sull’albero per aumentare la resa.
“L’olio spagnolo va corretto con altri più dolci, in Italia dicono che sa di urina di gatto e preferiscono comprare in Grecia”, racconta Leonardo D’Errico, che accusa i produttori spagnoli di anteporre i chili alla qualità. Dello stesso parere è Deoleo: “La qualità media dell’olio argentino e cileno, e ovviamente anche di quello italiano, è superiore a quella dell’olio spagnolo. Siamo un passo indietro sul fronte della qualità e non possiamo perdere questo treno”.
Verso il “made in Spain”
Dal 1990 il consumo di olio d’oliva è raddoppiato in tutto il mondo. Ciononostante l’oro liquido rappresenta appena l’1 per cento del consumo globale di oli vegetali, che è dominato da quelli di palma, soia, colza e girasole. Il margine di crescita quindi è enorme.
La preoccupazione riguarda ora l’offerta, secondo Jaime Lillo, direttore esecutivo del Consiglio oleario internazionale. L’olivo ha bisogno di meno acqua rispetto alla maggior parte delle altre colture, ma “la grande domanda è come si adatterà il bacino del Mediterraneo al cambiamento climatico”. Con piogge sempre più scarse e irregolari, l’accesso all’acqua sarà una questione centrale per la competitività degli oliveti, soprattutto in Spagna, che è il paese europeo con la maggior percentuale di suolo a rischio di desertificazione, il 74 per cento. Ma il 31 per cento delle colture sono già irrigue e gli oliveti continuano a estendersi lungo le rive del Guadalquivir.
Il potenziale produttivo di olio d’oliva in Spagna è di 2,2 milioni di tonnellate, tenendo conto dell’aumento di piantagioni dopo il picco produttivo del 2018/19, quando si è sfiorata quota 1,8 milioni. Ciononostante, non tutti vedono con favore questo scenario. Per Dcoop infatti “l’epoca delle vacche magre arriverà appena pioverà”. Un raccolto record farebbe crollare i prezzi delle vendite e obbligherebbe a ricorrere all’olio sfuso e alle riesportazioni italiane.
Gli agricoltori italiani protestano però contro l’”iberizzazione” della loro produzione olivicola, che nulla può contro il modello “superintensivo e monovarietale” spagnolo. L’Italia ha perso ormai da tempo la battaglia dei numeri, ma continua a essere la regina del marketing, aggrappandosi alla qualità del suo raccolto ridotto.
Le guerre dell’olio, lungi dall’essere acqua passata, si intensificano man mano che il business cresce e le sfide aumentano. In fondo, il marchio Spagna segue la scia del made in Italy.
👉 L'articolo originale su El Orden Mundial

In collaborazione con European Data Journalism Network
Ti piace quello che facciamo?
Contribuisci a far vivere un giornalismo europeo e multilingue, in accesso libero e senza pubblicità. Il tuo dono, puntuale o regolare, garantisce l’indipendenza della nostra redazione. Grazie!