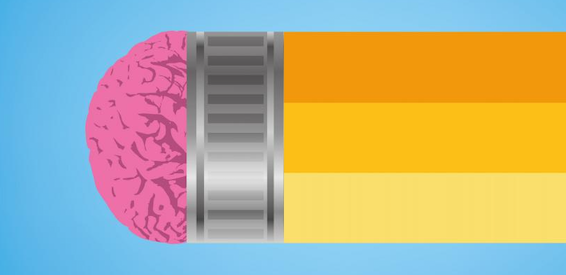L’era del mio cataclisma personale inizia il 21 aprile 1992. Quello fu il giorno in cui estremisti serbi armati, sostenuti dall'ex Esercito popolare jugoslavo, attaccarono Bihac, la mia città. Erano i nostri "vicini", concittadini, che si erano ritirati dalla città in un'azione concertata per attaccarci dalle montagne circostanti. L'attacco al mio paese era iniziato anche prima di questa data, perché il 21 aprile molte delle città al confine orientale con la Serbia (che allora si chiamava ancora Jugoslavia) erano già state distrutte. Nel momento in cui Slovenia, Croazia e Bosnia Erzegovina lasciarono la Jugoslavia, quello stato cessò nominalmente di esistere nella mente di tutti noi. Si è rivoltato contro tutti noi, noi che l'avevamo amato e contribuito al suo successo in ogni modo possibile.
Ogni cittadino della Bosnia Erzegovina porta questi due orologi, queste due cronologie, nel profondo della sua coscienza, nelle nostre menti, corpi e cuori.
Gli altri articoli della serie “Arcipelago Jugoslavia”:
- Kosovo, il fallimento della “vita migliore”
- Serbia, una vita sulla scena del delitto: “Ho visto il peggio della razza umana”
- In Slovenia sognavamo la democrazia e ci siamo svegliati con il capitalismo
- Bosnia Erzegovina, l’ora dell’apocalisse
- Scrivo di guerra non perché voglio, ma perché non ho scelta (Croazia)
Il primo orologio inizia a ticchettare nel momento in cui tutto è cominciato ufficialmente; il secondo è un orologio molto più importante, più personale, che misura il tempo dal momento in cui siamo stati cacciati dalle nostre case. Misura il tempo da quando siamo diventati rifugiati, o conta le ore dal momento della nostra ferita personale, la morte in guerra di qualcuno a noi caro. Alcuni orologi fanno il conto alla rovescia fino all'ora della nostra morte. Nella mia città, gli orologi di cinquecento soldati ticchettano finché noi, i sopravvissuti, viviamo. Finché ricorderemo i nostri amici, parenti e compagni di lotta morti.
È impossibile mettere nero su bianco tutto quello che si misura con questo orologio personale. Ci provo, da vent’anni, da quando ho cominciato ad apparire in pubblico come scrittore, ma so di essere andato appena oltre il punto di partenza. La tragedia di una sola persona è già indescrivibile, qui stiamo parlando delle tragedie di centinaia di migliaia di persone di questo paese.
Questa apocalisse avviene prima dell’effettiva distruzione fisica. Avviene silenziosamente, in modo invisibile. Il lettore attento di giornali può individuarne i segni. Troppo spesso prende la forma della disumanizzazione di certi gruppi sociali, individui o interi popoli.
Questo orologio personale è un orologio apocalittico. Ogni persona ne ha uno. La guerra è l'apocalisse, non c'era nessuno allora a dircelo. Così come non c'era nessuno, dopo la guerra, a dirci che stavamo vivendo nell'era post-apocalittica. Tutto quello che avevamo per spiegare il tipo di società nella quale stavamo vivendo era il termine tecnico – "società post-bellica" – consegnatoci da persone ben intenzionate basate all'estero.
La fredda terminologia del linguaggio accademico non può catturare tutte le implicazioni dell'orologio apocalittico. Non ne riconosce nemmeno l'esistenza, poiché il termine "società post-bellica" vede solo "parti in guerra". Non tutte le guerre hanno parti in guerra: a volte ci sono solo gli aggressori e gli aggrediti. Per questo il termine è del tutto sbagliato, così come è sbagliato e vergognoso il termine "guerra civile" che i benintenzionati stranieri usano per descrivere la nostra guerra, la nostra apocalisse.
L'apocalisse non consiste nella distruzione di città, villaggi, ponti, reparti di maternità e cimiteri. Per me l'apocalisse è il momento in cui tutti i valori della società civile vengono meno. Il momento in cui tutto ciò che è spaventoso, anormale e terribile diventa normale, socialmente accettabile, persino desiderabile.
Questa apocalisse avviene prima dell'effettiva distruzione fisica. Avviene silenziosamente, invisibilmente. Il lettore attento di giornali può individuarne i segni. Troppo spesso prende la forma della disumanizzazione di certi gruppi sociali, individui o interi popoli.
La storia di Željko Sikora
Per esempio, prima dello scoppio della guerra del 1992, il giornale Kozarski Vijesnik di Prijedor [città che è stata teatro di una pulizia etnica, ndr] ha pubblicato una serie di articoli che disumanizzavano i residenti di nazionalità bosniaca, croata e altre. In un caso, sia Kozarski Vijesnik che Radio Prijedor pubblicarono servizi su un ginecologo apprendista di Prijedor, il dottor Željko Sikora, che aveva "indotto aborti in donne serbe che portavano feti maschili e castrato neonati serbi". Nonostante fosse etnicamente ceco, il medico era considerato dai criminali come croato, poiché i nazionalisti serbi di allora equiparavano tutti i croati agli ustascia [i paramilitari fascisti croati durante la Seconda guerra mondiale].
Il quotidiano di Belgrado Ekspres politika lo soprannominò "il medico mostro". Il dottor Sikora, insieme a due medici di nazionalità bosniaca, è nominato nel rapporto ufficiale dell'allora Repubblica Federale di Jugoslavia alla Commissione di esperti dell'ONU sotto il titolo "Prove indiziarie di autori di trattamenti inumani di civili a Prijedor 1989-1992". Il loro crimine principale è elencato come la "soppressione sistematica del tasso di natalità tra la popolazione serba nel distretto di Prijedor per mezzo della castrazione dei neonati di nazionalità serba [...] Hanno usato una serie di farmaci ed esperimenti per sterilizzare i bambini nell'ospedale di Prijedor, e hanno deliberatamente sbagliato la diagnosi degli adulti di nazionalità serba e dato loro i farmaci sbagliati".
Come risultato di queste accuse nei mezzi d'informazione, il dottor Sikora fu assassinato nel campo di concentramento di Keraterm, un destino che condivise con migliaia di suoi concittadini di origine etnica "sbagliata" in altri campi. Il suo corpo è stato trovato vicino a un cassonetto. Prima di essere ucciso era stato quotidianamente picchiato.
Kozarski Vjesnik viene ancora pubblicato. Se fate una ricerca su Željko Sikora nell'archivio del giornale, non troverete alcuna informazione su di lui. Željko Sikora era l'ultimo discendente maschio della famiglia Sikora. Non è mai stato trovato uno straccio di prova per i suoi "crimini", né è mai stato processato. Ancora oggi, il suo nome non è stato ripulito da questa calunnia.
La disumanizzazione e la demonizzazione di gruppi, individui e interi popoli avveniva molto prima che la guerra scoppiasse in Jugoslavia. Lo scopo di questo approccio era quello di preparare la gente comune a considerare gli omicidi, i massacri e infine anche il genocidio come eventi perfettamente normali.
Sono diventato un rifugiato per la prima volta il 21 aprile 1992, e non credo che cesserò mai del tutto di esserlo adesso, perché la condizione di rifugiato non è solo uno status in qualche file della Croce Rossa: è la sensazione, nel profondo, di non appartenere a niente e a nessuno. Amo la terra in cui vivo, ma non come uno stato, solo come la terra: la somma dei suoi paesaggi e delle sue bellezze naturali.
Diventare un rifugiato è un processo totalmente indolore; ma ci sono altre parti invisibili di te che proveranno terribili dolori fantasma per anni dopo. "Arto fantasma" è il termine medico per indicare il dolore di un arto che non hai più, un arto che è stato amputato. Siamo stati amputati delle nostre vite precedenti alla guerra e questi dolori fantasma sono qualcosa che porteremo con noi fino alla tomba.
Sono diventato un rifugiato per la prima volta il 21 aprile 1992, e non credo che cesserò mai del tutto di esserlo adesso, perché la condizione di rifugiato non è solo uno status in qualche file della Croce Rossa: è la sensazione, nel profondo, di non appartenere a niente e a nessuno. Amo la terra in cui vivo, ma non come uno stato, solo come la terra: la somma dei suoi paesaggi e delle sue bellezze naturali.
Ci si confronta con la storia della propria vita e la si deve accettare, come tutte le cicatrici portate sul corpo e sull'anima. In questo modo si può continuare ad andare avanti, perché in guerra l'unica cosa che non può essere distrutta da una granata d'artiglieria è la vita stessa. Il desiderio di vita è più grande e più forte di tutto il resto.
E così ho preso la mia arma e sono diventato un soldato.
Quando intervengo facendo delle letture in altri paesi mi viene spesso chiesto se ero volontario. Ogni volta per me è problematico rispondere: come posso spiegare che sono stato cacciato dalla mia casa, dalla mia strada e dal mio quartiere, solo perché i miei occhi erano di un colore diverso? Naturalmente ho preso la mia arma, che in realtà era solo una pistola, dato che nell'aprile del 1992 non eravamo esattamente ben armati.
Il mondo esterno, sotto la forma delle Nazioni Unite, aveva imposto un embargo sulle armi al nostro paese, abbandonandoci così al nemico, che invece era armato fino ai denti.
La ragione per cui fummo piantati in asso fu che la propaganda nemica era stata molto efficace nel ritrarci come tessuto estraneo nel corpo dell'Europa. Siamo stati etichettati come musulmani assetati di sangue, la minaccia verde, mujahiddin, anche se molti di noi erano atei, laici, jugoslavi, bosniaci, di sinistra, cosmopoliti, new wavers, punk ecc. Tutte queste identità sono state uccise e sepolte. E mentre questo accadeva, certi politici europei parlavano della "dolorosa ma realistica restaurazione dell'Europa cristiana". Siamo stati le cavie nello sviluppo dell'islamofobia su scala globale che vediamo oggi all’opera.
Non ero affatto un volontario, prendere le armi non fu una questione di libero arbitrio: ero costretto a combattere per la mia sopravvivenza biologica. Nell'aprile del 1992 eravamo già circondati da tutti i lati: non era quindi possibile fuggire dalla guerra e fare il pacifista saccente che sentenziava a distanza di sicurezza sulle parti del conflitto.
Ho scritto numerose poesie, racconti, un romanzo e molti articoli sulle mie esperienze di soldato in guerra, sarebbe quindi superfluo ripeterelo qui. Ero un membro dell'esercito della Bosnia Erzegovina, non un esercito "musulmano" come ci chiamavano sia il nostro nemico che gli osservatori internazionali nel 1992-95. A un certo punto il mio piede sinistro è stato gravemente ferito e ho passato la metà di un anno con le stampelle. In seguito sono tornato alla mia unità, riprendendo i compiti che avevo svolto prima dell'infortunio. Sono diventato capo plotone (il pilastro di ogni esercito) e verso la fine della guerra guidavo 130 uomini in azioni offensive. Come la maggior parte delle persone in Bosnia Erzegovina, avevo il Ptsd (Post-traumatic stress disorder, Disturbo da stress post-traumatico), i cui effetti si fanno sentire solo quando la guerra è finita.
Siamo stati le cavie nello sviluppo dell'islamofobia su scala globale che vediamo oggi all’opera.
Ho ricevuto diverse decorazioni per le mie imprese militari, sia durante che dopo la guerra.
Quando la guerra è finita ho cercato di tornare a quello che ero stato prima, uno studente di veterinaria al terzo anno. Ma presto ci rinunciai e mi iscrissi invece a Lettere. Cominciai a scrivere ogni giorno su una macchina da scrivere Olympia Monica del 1967. Volevo diventare un autore, ed è quello che ho fatto.